
La prima volta che li ho visti eravamo nei pressi di Mekelè, sul confine con la depressione della Dancalia, dove avevamo sperato di fare una breve escursione, e dove invece era da tempo proibito recarsi, sia per i pericoli della regione – la più bassa depressione e la più alta temperatura del globo, con vulcani perennemente attivi e laghi di sale –, sia per la mancanza di controllo politico sulla zona da parte dello stato etiope. Ci eravamo fermati sulla strada che poi si inoltrava verso la Dancalia ad aspettare il ritorno dall’inferno di qualche carovana di cammelli, perché qualcuna non aveva mai smesso di andare a prendere i carichi di sale. Ci mettemmo a camminare in avanti, per una strada tra ondulazioni spoglie, aride, di un giallo-sabbia dominante, senza persone, abitazioni, sperando di intravedere da qualche altura qualcosa della magica depressione. Ad una svolta invece, ecco dei bulldozer che stavano scavando per aprire in ampiezza la strada. Nel nulla. Dove non passava nessuno e anche le carovane erano rare, di pochi cammelli, poverissime. Gli operai alle vanghe erano neri. Arrivò poi quel che apparve il direttore dei lavori. Cinese. Sapevamo già come i cinesi in Africa e in Etiopia in particolare si davano da fare per arraffare terre, mercati, minerali e quant’altro; e avevamo visto qualche raro ciclista etiope su bici cinesi allenarsi per ripide salite. Ma quella strada ci sembrò proprio la più inutile delle follie.

viabilità verso la Dancalia.
Finché, non ricordo più in che altra zona, non imboccammo col pulmino un’ampia stradona asfaltata – una rarità, rispetto alle tante quasi mulattiere incontrate per raggiungere molte delle nostre mete rupestri – che ci fece gioire la schiena finché non entrammo nell’orrore. La strada, per allargare la precedente via che attraversava un piccolo paese, aveva costretto ad un taglio perfetto di tutte le abitazioni che si affacciavano
sui due lati, per lo più baracche di legno e fango secco. Di sicuro non era stato difficile, come tagliare una torta morbida: avevano affettato di uno due metri – o più – la porzione di legno e fango che dava sulla strada dove adesso si affacciavano i monconi delle stanze, per lo più ancora spalancati o pudicamente nascosti da tende. Era come vedere corpi potati. Chissà quelli che ci abitavano, chissà se gli avevano dato qualche soldo, qualche chimerica promessa, chissà come vivevano in quelle stanze mozzate. In compenso la stradona, per tutto l’attraversamento del paese, era stata divisa in due carreggiate da una bella banchina in cemento da cui svettavano, altissimi giganteschi, tanti moderni lampioni, come quelli comparsi a Lhasa ai piedi del palazzo del Potala. Senza lampadine, perché lì non ci arrivava l’elettricità, ma facevano un gran bel figurone di modernità e futuribile progresso in confronto con quelle baracche affettate.

via ‘allargata’
Quando passammo per l’Amba Aradam, un altopiano di otto chilometri a sud di Mekelé, finalmente potemmo far combaciare il significato comune, nel nostro parlato, di ambaradan – cioè: casino, confusione, caos – con la sua ignoratissima origine. Perché a noi italiani-brava-gente non piace stare a tornar su queste storie un po’ ridicole di colonialismo; che poi fu all’acqua di rose, non fosse stato per quell’esaltato di Rodolfo Graziani che si lasciò prendere la mano dalla rabbia, soprattutto ad Addis Abeba, e fece un bel po’ di morti. Qui, ad Amba Aradam, nel 1936, in febbraio, l’esercito etiope, armato alla bell’e meglio, si oppose alle armate italiane che puntavano a conquistare l’Etiopia con qualsiasi mezzo, anche con l’uso di bombe caricate con gas nervini. Cinque giorni di assalti italiani con bombardamenti continui contro armi abissine poco più moderne di archi, in una situazione talmente confusa e caotica da far portare a casa il nome del posto come sinonimo di ‘casino’, altro che grandiosa vittoria dell’Impero, come invece venne propagandata dopo il ritiro dell’esercito etiope.
Da quelle parti, non ricordo più il posto, arrivammo poi ad un piccolo cimitero di caduti italiani in quella guerra d’invasione: alcune camicie nere, molti soldati comuni – magari falciati dall’ameba –, alcuni ufficiali. Tombe ben tenute e ordinate; piante verdi, qua e là, compatibili col clima; recinzione e opere in muratura semplici, ma dignitose. Guardiani manutentori etiopi. Mi sono vergognata. Per l’ostilità, la rabbia, il bisogno di dichiararmi contro che mi faceva guardare e dire male di alcuni nomi, di alcune scritte fasciste sulle tombe e in generale del significato di quei morti. Mentre loro, gli etiopi – o meglio: la gente comune che incontravamo, oltre che qui, anche in altri momenti di confronto – continuavano a farci sentire che per loro era storia chiusa, da ricordare e far ricordare: ma non per rinfocolare odio e ostilità, quanto piuttosto per non averne repliche mai.



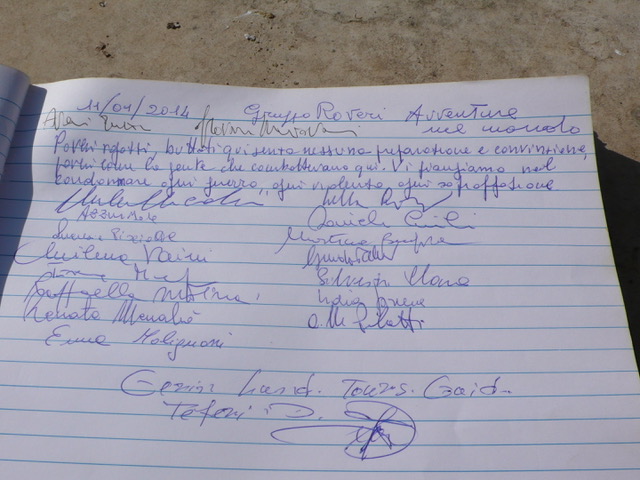
Un giorno, passando sotto un piccolissimo villaggio, ci vennero incontro, ruscellando giù da una collinetta, tanti bambini bambine e ragazzi ragazze, tutti festanti, come succedeva quasi sempre. L’autista frenò il nostro impulso a distribuire penne, caramelle e magliette, dicendoci con molta severità che così li avremmo abituati all’accattonaggio, e che, se avessimo voluto aiutare, avremmo dovuto farlo tramite le associazioni preposte. Il bimbo che aveva solo una lisa maglietta addosso e nude al vento le sue pudenda, la ragazzina che aprì la mantellina tenuta chiusa con le mani e mostrò nudo il suo esile corpo, gli occhi di tutti, bellissimi in quei visi bellissimi e magri, non smisero di sorriderci e salutarci festosi anche quando partimmo senza aver lasciato niente (forse qualcuna di nascosto aveva dato). C’era un grande albero alle loro spalle, solo quello, e, sulla collinetta dietro, qualche capanna, talmente poca da ricordare l’era arcaica lì dei primi ominidi.
Poco tempo fa ho rinnovato il contributo per i bimbi dell’Etiopia, affamati e violentati da un’ennesima guerra, da un’ennesima carestia, raccomandandomi che andasse proprio a loro. Stupidamente, perché la fame e il bisogno fanno uguali tutti nel mondo. E di nuovo con vergogna, come quando si prega per chiedere un aiuto divino, implicitamente sperando di potere essere esauditi e quindi scelti e quindi privilegiati tra tutti gli altri supplici. Ma soprattutto sapendo che per quel bambino là e quella ragazzina là e tutti quegli altri dagli occhi belli non sarebbe cambiato niente.
Se non cambia un mondo che divide chi guarda da chi va nudo nella fame.

dalla Dancalia

Lascia un commento